|
Economia e felicità
Crescita economica, benessere percepito e comportamenti relazionali
di Luigi Mittone e Maurizio Pugno*
 |
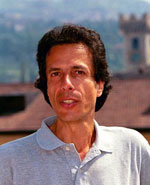 |
Ma la felicità non è un argomento per filosofi e poeti?
L’economia non studia forse grandezze misurabili, e possibilmente misurabili con
il metro monetario? Se alcuni economisti a Trento si avventurano in questo campo
non rischiano una ricerca inconclusiva? Per rassicurare il lettore davanti a
queste domande va ricordato che recentemente alcuni fatti hanno attratto
l’interesse per la felicità di un numero crescente di economisti, soprattutto a
livello internazionale, i quali si sono messi a studiarla a loro modo.
Un fatto macroeconomico è ormai comprovato: che nei decenni più recenti il trend
di crescita economica dei paesi avanzati non si accompagna ad una analoga
crescita della valutazione che la popolazione dà del proprio benessere
complessivo, economico ed extra-economico. Per alcuni paesi, come il Giappone,
questa autovalutazione indica, piuttosto, un benessere stazionario, per altri,
come gli Usa, addirittura decrescente. Altri indicatori del benessere percepito
dagli individui, come il tasso di suicidi e la diffusione della depressione,
sembrano aggravare una conclusione che suona in modo particolarmente
preoccupante per gli economisti. Vale a dire, il benessere economico
sintetizzato dal reddito procapite, che costituisce la variabile-obiettivo
finale degli economisti, sovrastima il benessere complessivo delle persone in
modo crescente. Questo viene anche chiamato “paradosso della felicità”.
In ambito microeconomico, numerosi studi di psicologi economici e di economisti
hanno riscontrato in via sperimentale una serie di “anomalie” nel comportamento
degli individui, rispetto a quanto avrebbe previsto la teoria classica della
scelta razionale (colonna portante della teoria economica tradizionale), che
dovrebbe assicurare la massimizzazione del benessere individuale. Una anomalia
particolarmente studiata è quella dell’altruismo, che violerebbe il principio
dell’autointeresse che ispira la teoria economica. Sembra infatti comprovato che
in diversi casi in cui le persone prendono una decisione che coinvolge altre
persone, siano disposte a sacrificare la massimizzazione del proprio tornaconto
personale per avere un esito più equo.
Sia in ambito macroeconomico, sia in quello microeconomico, dunque, gli
economisti sono posti davanti alla necessità di rivedere i loro tradizionali
principi e strumenti d’analisi, se non vogliono rischiare di vedere condannate
le loro conclu sioni e prescrizioni alla scarsa rilevanza. sioni e prescrizioni alla scarsa rilevanza.
Non sorprende a questo punto che all’interno della Facoltà di Economia di Trento
ci sia stata la sensibilità di cogliere questi problemi per farne oggetto di
ricerca. Si ricorda ad esempio che questa Facoltà ha conferito la laurea
honoris causa a Daniel Kahneman, che è uno dei più noti psicologi economici
e studiosi delle “anomalie” nel comportamento razionale, ora Nobel per
l’economia. Pertanto, benché il filone di ricerca sia molto nuovo a livello
nazionale (non esi- stono, a nostra conoscenza, progetti di ricerca in questo
filone finanziati con fondi del Miur o con fondi europei), Trento si trova
avvantaggiata per la sua storia di ricerche in economia cognitiva, che studia i
fallimenti della razionalità (sostantiva), e in economia sperimentale.
Attualmente, a questo filone di ricerca sono direttamente interessati tre membri
del Dipartimento di Economia (Luigi Mittone, Maurizio Pugno, Paola Villa), ma
altri membri conducono ricerche strettamente connesse (Carlo Borzaga, Massimo
Egidi). La ricerca è focalizzata su due punti, uno di prospettiva macroeconomica
(Pugno), l’altro di tipo microeconomico-sperimentale (Mittone, Villa), legati da
un preciso nesso: il ruolo cruciale dei rapporti interpersonali nel
comportamento umano.
Da una prospettiva macroeconomica si intende trovare una spiegazione al
“paradosso della felicità” considerando esplicitamente che il benessere
soggettivo è spiegato sia dal consumo di beni tradizionali, sia dall’esperienza
dei rapporti interpersonali.
Tuttavia, mentre il benessere atteso dal primo è relativamente certo, il
benessere atteso dalla seconda no.
Le delusioni conseguenti i rapporti interpersonali, indurrebbe dunque a
consumare di più i beni, e deteriorare la propria disposizione e le esperienze
stesse di rapporto con gli altri.
Un primo risultato di questa ricerca è stato la presentazione di una relazione
al convegno internazionale Paradoxes of happiness in economics
(Università Bicocca di Milano, 21-23 marzo 2003), che ha visto l’adesione di
decine di studiosi economisti, sociologi e psicologi. A gennaio è uscito il
volume Felicità ed economia (Guerini e Associati) che seleziona alcuni
contributi (tra cui quello di Pugno). A fine anno uscirà u n secondo articolo
nel volume Handbook of happiness in economics (Elgar). È inoltre in
programma una conferenza su Economia e felicità presso la Facoltà di
Economia in cui si discuterà con Luigino Bruni (Università Bicocca) e Stefano
Bartolini (Università di Siena) come nasce il “paradosso della felicità”,
 e se
ci sono rimedi perché la politica economica aumenti realmente il benessere. e se
ci sono rimedi perché la politica economica aumenti realmente il benessere.
Dal punto di vista microeconomico-sperimentale, si intende studiare se
l’altruismo, una volta opportunamente definito, gioca un ruolo significativo ed
in quali contesti (Mittone), e se esiste una differenza fra i sessi in tali
comportamenti (Villa). L’approccio sperimentale si presta particolarmente bene
ad esplorare la relazione che intercorre tra le variabili tipicamente economiche
(reddito, consumi, ecc.) e le variabili psicologiche, che tanta parte hanno
nella percezione del nostro benessere. Nel laboratorio dell’economista
sperimentale è infatti possibile isolare artificialmente gli effetti prodotti da
ogni singolo elemento della complessa rete che forma la vita sociale delle
persone. In questo modo è possibile calibrare l’importanza di ogni componente
relazionale sulla determinazione di quel complesso stato d’animo che definiamo
genericamente con il termine felicità. Ad esempio è possibile capire se un
concreto atto di sacrificio, magari la rinuncia ad una parte del nostro reddito,
prodotto da un sentimento altruistico non sia in realtà mosso da un inconscio
desiderio di provare un senso di autostima che sostiene il delicato equilibrio
tra il benessere materiale e quello emotivo. Nello stesso modo la leva che ci
spinge ad opporci alle discriminazioni, a partire da quelle contro le donne,
potrebbe essere imperniata sul bisogno di sentirci parte di un ambiente equo e
tollerante, in cui la nostra percezione di benessere individuale non sia minata
dalla consapevolezza dell’esistenza dell’infelicità altrui.
Attraverso lo studio dei comportamenti economici nel contesto controllato ed
artificiale del laboratorio si può gettare luce sui limiti della caricaturale
immagine dell’homo oeconomicus, per cercare di proporre una nuova
definizione della razionalità economica.
Su questa linea di ricerca il Dipartimento di Economia di Trento vanta una
esperienza ormai pluriennale, per principale merito di Massimo Egidi e di Axel
Leijonhufvud che hanno creato una complessa rete di relazioni con studiosi
interessati all’esplorazione di nuovi paradigmi in economia. Tra i più celebri
si possono citare i premi Nobel Herbert Simon - purtroppo venuto a mancare pochi
anni fa - e Reinhard Selten che hanno fortemente incoraggiato le linee di
ricerca sostenute dal Dipartimento in questi campi di frontiera.
*Luigi Mittone, Dipartimento di Economia e Computable and
Experimental Economics Laboratory, Maurizio Pugno, Dipartimento di Economia.
|